“Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche.“
Jean-Paul Sartre
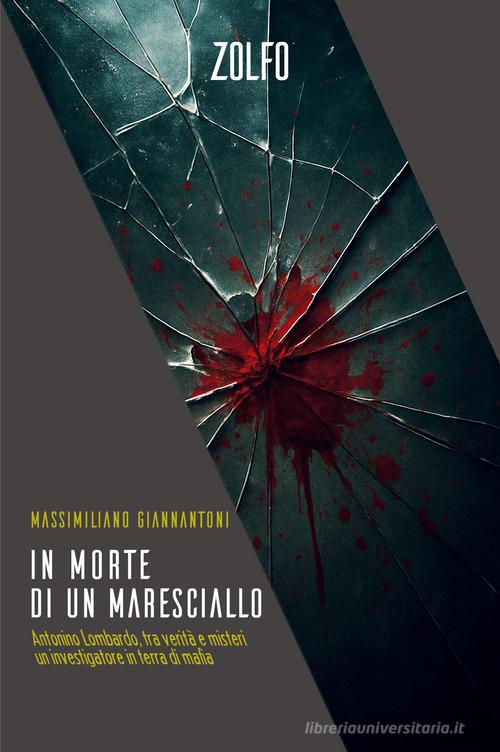
Non avrei verosimilmente concepito l’idea di approcciarmi alla lettura del volume intitolato “In morte di un maresciallo”, opera di Massimiliano Giannantoni edita da Zolfo Editore, se non fosse per una circostanza peculiare: un silenzio, di natura inequivocabile e studiata.
La mia potenziale ritrosia non è affatto dovuta alla mancanza di stima per l’autore, la cui professionalità giornalistica è indiscussa. Al contrario, essa scaturisce proprio dalla sua adesione rigorosa ai canoni dell’inchiesta, con l’accurata ricognizione di fonti e documenti a supporto della narrazione. Sebbene tale rigore risulti indispensabile per la stragrande maggioranza del pubblico, che ignora i dettagli della vicenda, esso potrebbe rivelarsi di utilità marginale per gli “addetti ai lavori” che nel corso degli anni, hanno già avuto modo di compulsare gli atti, esaminare le risultanze iconografiche, confrontarsi con esperti e pervenire alla convinzione che il maresciallo Antonino Lombardo, fidato collaboratore e amico di Paolo Borsellino, non sia deceduto per mano propria, ma sia stato vittima di omicidio.
Non nutro, dunque, l’aspettativa di rivelazioni sensazionali o della prova definitiva che l’eliminazione del Maresciallo Lombardo sia avvenuta all’interno della sua vettura ad opera di un “convitato”, come pure si potrebbe inferire dalla pulizia immacolata di un sedile, dalla traiettoria anomala del proiettile – il cui angolo di incidenza dall’alto verso il basso è peculiare – né tantomeno mi attendo la dimostrazione che l’autovettura sia stata movimentata a motore spento e collocata in loco, come suggerito dalle molteplici incongruenze, a partire dal finestrino abbassato in una serata dalle condizioni meteorologiche avverse. Un finestrino, peraltro, la cui apertura era presumibilmente necessaria per manovrare il volante dall’esterno, consentendo l’introduzione dell’auto nel cortile della caserma e il suo posteggio finale.
Non è questo, lo ribadisco, l’oggetto della mia attesa. Non lo è poiché un giornalista coscienzioso aderisce ai fatti documentati, e non lo è in virtù della consapevolezza delle gravi ripercussioni cui l’autore andrebbe incontro nel gettare ulteriori, e ben più fitte, ombre su determinati apparati statali, in particolare su una specifica Istituzione che parrebbe avere responsabilità iniziali ben superiori a quelle della Magistratura che in seguito omise di approfondire le indagini.
Cosa mi induce, dunque, a procedere all’acquisto e alla lettura di “In morte di un maresciallo”? Il silenzio.
Nello specifico, il silenzio che promana dai social group istituiti per perpetuare la memoria del giudice Borsellino. Quali contenuti di questo testo potrebbero risultare “sgraditi” a coloro che quotidianamente diffondono documenti e formulano ipotesi sulla strage di Via D’Amelio?
Non si tratta, con ogni probabilità, delle critiche mosse alla Procura dell’epoca per la conduzione lacunosa delle indagini – eventi successivi alla morte di Lombardo – bensì degli avvenimenti occorsi quella sera stessa all’interno della Caserma Bonsignore di Palermo, sede del comando regionale dei Carabinieri. Perché mai Lombardo, prima di essere presumibilmente “suicidato”, si rivolse alla vedova Agnese Borsellino asserendo che a breve le avrebbe recapitato “su un vassoio d’argento” la verità sulla morte del consorte?
Lombardo non poteva certamente alludere alla responsabilità di Salvatore Riina, già assicurato alla giustizia, né al “nido di vipere”, espressione con cui lo stesso Borsellino aveva stigmatizzato la Procura di Palermo, a meno di non postulare che i mandanti della strage fossero da ricercare tra uomini in toga.
È proprio tale eloquente reticenza ad avermi persuaso della necessità imprescindibile di leggere il saggio di Massimiliano Giannantoni. Un testo che si prefigura come un catalizzatore per ridestare l’attenzione sul caso Lombardo, con i suoi numerosi interrogativi e le lunghe ombre che si proiettano su taluni apparati dello Stato, e non solo dello Stato, lasciando preludere a interessi che andavano ben al di là della becera mafia e di una questione tutta e solo italiana.
Un volume, in sintesi, che si annuncia ricco di elementi esplicativi per il lettore comune, ma il cui singolare silenzio circostante lo rende parimenti significativo anche per chi è già edotto sui fatti. Un’opera, in ogni caso, meritevole di attenta consultazione.
Gian J. Morici






