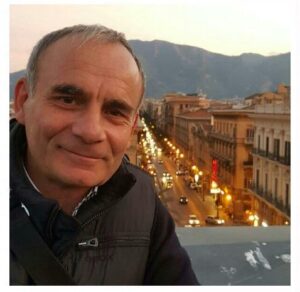di Carlo Ruta
 C’è buio davanti. L’isolamento sociale prolungato, ad una sola velocità e in un solo senso, decretato per l’intero Paese malgrado le forti sproporzioni del contagio da regione a regione, ha fermato risorse ingenti, che invece potevano essere mobilitate per scongiurare il tracollo economico e sopperire in qualche misura ai vuoti produttivi delle zone più infettate. Poteva andare meglio in realtà, ma nel fuggi fuggi dell’Europa è sopravvenuto il caos. L’orgoglio di un Nord italiano che ha creduto troppo nel proprio ruolo-guida e nella sacralità del proprio sistema imprenditoriale, restio a recitare perciò la parte dell’infermo bisognoso d’aiuto al cospetto di un Centro-Sud meno colpito dall’infezione, probabilmente ha pesato sulle scelte e l’adozione dei paradigmi. Ma a creare disappunto non sono soltanto le supponenze dell’Italia più industriale e finanziaria.
C’è buio davanti. L’isolamento sociale prolungato, ad una sola velocità e in un solo senso, decretato per l’intero Paese malgrado le forti sproporzioni del contagio da regione a regione, ha fermato risorse ingenti, che invece potevano essere mobilitate per scongiurare il tracollo economico e sopperire in qualche misura ai vuoti produttivi delle zone più infettate. Poteva andare meglio in realtà, ma nel fuggi fuggi dell’Europa è sopravvenuto il caos. L’orgoglio di un Nord italiano che ha creduto troppo nel proprio ruolo-guida e nella sacralità del proprio sistema imprenditoriale, restio a recitare perciò la parte dell’infermo bisognoso d’aiuto al cospetto di un Centro-Sud meno colpito dall’infezione, probabilmente ha pesato sulle scelte e l’adozione dei paradigmi. Ma a creare disappunto non sono soltanto le supponenze dell’Italia più industriale e finanziaria.Malgrado si sia giunti verosimilmente al giro di boa, l’infezione tormenta ancora il Paese. I morti restano, in rapporto agli abitanti, tra i più numerosi al mondo, nonostante le rigide misure dell’isolamento sociale. Oggi, 23 aprile, superano i 25.000, e l’andamento della curva lascia prevedere, ad una stima prudente, che, alla chiusura di questa fase, possano superare i 30.000: qualcosa come 5 volte la somma dei morti di tutti i terremoti avvenuti nella penisola e nelle isole dal secondo dopoguerra. Non si tratta evidentemente di un trauma, ma di una voragine apertasi nella vita del Paese. E questa voragine morale e materiale sta allargandosi con l’emergere di nuovi disastri, economici in primo luogo, che, come dimostrano le stime di caduta possibile del Pil nel primo semestre, nell’ordine del 15% secondo gli analisti, graveranno sulla società italiana e in maniera dirompente sui ceti meno garantiti.
Adesso, davvero, è tutto più difficile, ed è curioso che, invece di correggere le rotte là dove è necessario, si insista a navigare a vista e a braccia. Solo condotte sicure sul campo, sostenute da politiche lungimiranti, perfettamente in linea con i principî fondamentali della Costituzione, possono aiutare il Paese a fuoriuscire dal disordine materiale e morale in cui è ridotto. Ma c’è ben poco di confortante quando si pensa, appunto, ai regionalismi boriosi che persistono, a dispetto dei tantissimi morti, e alla mancanza, ancora oggi, di un piano coeso sui dispositivi di protezione, che con regole precise di distanziamento sarebbero dovuti essere la base strategica del contrasto all’infezione, fin dal primo momento.
L’Italia sta diventando più povera, gli analisti della fase sostengono che uscirà più colpita di altri paesi europei dell’Unione, e questo annuncia gap ulteriori, con erogatori di denaro che si porranno in campo con nuova lena per nuocere al Paese, ben al di là delle fenomenologie criminali dei «capibastone», di cui si parla in questi giorni. Si faranno avanti, è facile immaginarlo, le facoltose banche d’affari europee e globali, le lobby, le corporation, gli accaparratori di risorse primarie, di beni comuni e della comunicazione, i capitalismi asiatici, i colossi dell’e-commerce. Si annunciano, ad esempio, già tentacolari le mosse di Amazon, che cresce vorticosamente sulle ali del «lockdown» mentre si contraggono sempre più i commerci cittadini, che a lungo hanno garantito e stabilizzato le economie territoriali.
La posta stavolta è davvero alta. Si può imboccare un percorso di rinascita civile e responsabile, con il concorso fondamentale delle comunità, o andare incontro a situazioni ibride, incerte, aperte ad ogni compromesso. Le povertà crescenti, gestibili ad hoc per alimentare nuove chiusure, impoveriscono il paese civile, e un paese impoverito è più soggetto all’attacco predatorio, esterno e interno, nemico e «amico». È difficile valutare, o solo immaginare, quanto le condotte politiche di questi tempi possano ipotecare il futuro di tutti, la vita sociale, la scuola, l’università, l’organizzazione del lavoro, l’industria, la sanità extra-covid, che è finita in queste settimane ai margini, pressoché implosa. Non è ancora tempo per comprendere appieno i danni che ne avranno le nuove generazioni e gli anziani, che rischiano di finire tra più fuochi. Sono tuttavia bene ipotizzabili i danni del patrimonio culturale, che, detenuto dallo Stato e amministrato da una pluralità di enti e articolazioni, costituisce una delle risorse più imponenti del Paese, perfino strategica sul piano globale. Ed è proprio il carattere strategico di questo comparto, colpito da decenni da tagli di spesa devastanti, a suggerire alcune considerazioni.
In un Paese che finisce alle corde, rischi serissimi corrono i musei, i parchi, i siti archeologici, i centri storici d’arte, gli orti botanici, le pinacoteche, il patrimonio monumentale, i luoghi di culto, gli archivi, le biblioteche storiche. Forse non si arriverà a quel che abbiamo visto in questi decenni di guerre «morali», «giuste», «democratiche» e, perché no, «umanitarie». Penso ai tantissimi reperti provenienti dai musei dell’Iraq, della Siria e di altre aree mediorientali che sono finiti all’asta su Ebay, ceduti spesso, pensate un po’, per pochi dollari, o quelli che, dopo essere scomparsi, sono riapparsi quasi magicamente nelle collezioni private di miliardari, non soltanto americani.
In un’Italia impoverita diventa sempre più elevato il rischio che opere d’arte si sgretolino fino a perdersi negli scantinati dei musei e può essere addirittura la fine per tante biblioteche, anche strategiche, in affanno già oggi per la carenza endemica di fondi. Possono crearsi allora spazi aggiuntivi per commerci opachi, sotterranei, per le svendite, mentre rischiano di saltare definitivamente i limiti posti finora alle cartolarizzazioni e alle privatizzazioni, fino a mortificare fino in fondo l’essenza pubblica e comune dei beni culturali. L’Italia ha perso la Fiat ed è rimasta sé stessa, ma se perde la pienezza di governo sui suoi beni culturali rischia di essere un paese moralmente finito, privo di anima, risucchiato dalle logiche della subalternità e dell’indifferentismo, del chi offre di più, alla maniera di quel «Franza o Spagna» di cui parlava, nel XVI secolo, Francesco Guicciardini.
Le culture possono essere ridotte in cenere. La biblioteca di Alessandria lo fu in vari momenti dell’età antica, per scomparire nel VII secolo definitivamente. I paesi civili possono collassare in un attimo, sotto la spinta di catastrofi, naturali, belliche, economiche. La civiltà minoica fu buttata giù da improvvisi disastri naturali, terremoti e maremoti. La Cartagine punica fu spazzata via, nel 146 a.C., dal puntiglio imperialistico di una parte dell’aristocrazia romana, sotto l’istigazione ideologica di Catone. Appare poi particolarmente istruttivo il messaggio dell’Atene classica, che dopo aver raggiunto vette decisive, nel V secolo a.C., nelle scienze, nelle lettere, nella filosofia, nel teatro e nelle arti plastiche, sprofonda nelle guerre, nella peste e nella tirannia, per toccare il fondo nel 399 a.C., quando, in una parvenza di regime democratico decreta nell’agorà cittadina la morte di Socrate. E tuttavia proprio l’esperienza greca dà conto di quanto la storia sia aperta nei suoi processi e nelle sue pieghe: alla decadenza succedette infatti una rimonta intellettuale epica, introdotta dall’aristotelismo e sparsa in tutte le aree mediterranee dall’ellenismo post-alessandrino.
L’Italia può allora ripartire. La china può essere risalita. Esistono partite da giocare, e si può giocarle da protagonisti, non da subalterni. Si può organizzare un cammino aperto, ripensare il Paese, un civismo più a misura dei tempi, nel rispetto appunto dei principî del ’46. Si può, ma solo se lo si vuole, dare corso ad una grande svolta umanistica, facendo pace, anzitutto, con la natura. È tempo di cambiare passo. Lo si è fatto nel passato, anche in tempi più tragici. Lo si può fare adesso.