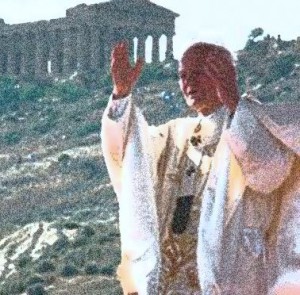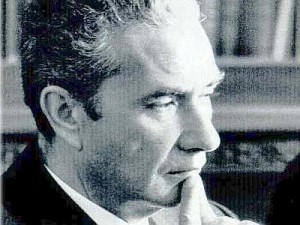Il Giappone, qualche giorno fa, è stato colpito da un violento terremoto accompagnato dalla furia del mare che ha riversato sulle coste nipponiche un devastante tsunami. Il bilancio della catastrofe naturale si aggrava di ora in ora. Inoltre, i sopravvissuti, in queste ore, devono convivere con le ansie e le paure determinate dal il rischio e dall’emergenza del nucleare. Le notizie sulle ultime esplosioni ed incendi avvenuti nella centrale nucleare di Fukushima, e le immagini di bambini con le mascherine protettive sul viso, risuonano attraverso radio, tv e internet ininterrottamente, turbando profondamente tutti noi. Di fronte a queste notizie la paura costituisce una reazione comune, ma mentre l’adulto ha delle risorse già ben strutturate che gli consentono di reagire, se non nell’immediato, in maniera adeguata alla realtà, i bambini, autoctoni e non, non riescono a gestire eventuali stati d’ansia e di forte paura legati proprio a tale evento. Essi, appaiono particolarmente spaventati da notizie riguardanti disastri naturali e guerre, soprattutto qualora la vittima sia rappresentata da un coetaneo.
Afferma Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro: “Ogni bambino sperimenta durante la sua crescita diverse paure ‘fisiologiche’ che vengono poi superate col tempo e con l’affetto dei genitori. Oltre a queste ne esistono altre che possono svilupparsi in risposta ad eventi particolarmente drammatici, come quello che sta accadendo in Giappone”.
Le manifestazioni più evidenti di queste paure sono diverse e possono essere riconosciute. Si tratta di ansia rispetto alla propria incolumità e a quella dei propri cari, talvolta accompagnata da comportamenti tipici dell’età evolutiva, come la richiesta di una maggiore vicinanza e attenzione da parte dei genitori, paura del buio, pipì a letto e disturbi del sonno. Il bambino può reagire anche manifestando ansia da separazione, disturbi della concentrazione, aggressività, malessere fisico e calo di interesse per le attività abituali.
Può accadere che il vissuto di questi bambini faccia emergere emozioni antagoniste, conflittuali, polarizzate, in quanto, hanno l’esperienza delle sicurezze di base date dalla relazione con le figure di accudimento, ma non riescono ad attingere né alle loro sicurezze e, probabilmente, né ai loro caregiver per avere dei punti di riferimento. Tutto ciò genera vuoto, angoscia smarrimento.
Quali sono le conseguenze, le ripercussioni psicologiche che possono avere i giapponesi tutti ma anche noi?
I disturbi che si possono sviluppare rientrano nell’ampio spettro dei Disturbi d’Ansia, quelli che riporto a mio parere sono i più frequenti e più significativi, nello specifico:
il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD): Nel DSM-IV la diagnosi di PTSD si pone quando una persona, esposta ad eventi traumatici, sviluppa sintomi duraturi intrusivi, di evitamento e di iperattivazione.
Nell’evento traumatico sono presenti entrambe queste caratteristiche:
o la persona ha vissuto, assistito, o si è confrontata con un evento che ha implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni o una minaccia all’integrità fisica propria o di altri;
o la risposta della persona comprendeva paura intensa, sentimenti di impotenza, o di orrore.
Il soggetto rivive persistentemente l’evento in uno, o più, dei seguenti modi: ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi dell’evento che comprendono immagini, pensieri, o percezioni. Nei bambini piccoli si possono manifestare giochi ripetitivi in cui sono espressi temi o aspetti riguardanti il trauma;
2. sogni spiacevoli ricorrenti dell’evento. Nei bambini possono essere presenti sogni spaventosi senza un contenuto orribile;
3. agire o sentire come se l’evento traumatico si stesse ripresentando (sensazioni di rivivere l’esperienza, illusioni, allucinazioni, episodi dissociativi di flashback). Nei bambini piccoli possono manifestarsi rappresentazioni ripetitive specifiche del trauma;
4. disagio psicologico intenso all’esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell’evento traumatico;
5. reattività fisiologica o esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell’evento traumatico.
Si verifica un evitamento persistente agli stimoli associati con il trauma e vi è un’attenuazione della reattività generale:
1. sforzi per evitare pensieri, sensazioni, o conversazioni associate al trauma;
2. sforzi per evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi del trauma;
3. incapacità di ricordare qualche aspetto importante del trauma;
4. riduzione marcata dell’interesse o della partecipazione ad attività significative;
5. sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri;
6. affettività ridotta (es. incapacità di provare sentimenti di amore, affetto…);
7. sentimenti di diminuzione delle prospettive future (es. aspettarsi di non poter avere una carriera, un matrimonio o dei figli o una normale durata della vita).
Sintomi persistenti di aumentato arousal:
1. difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno;
2. irritabilità o scoppi di collera;
3. difficoltà a concentrarsi;
4. ipervigilanza;
5. esagerate risposte di allarme.
Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione nel funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.
Nel caso di un vissuto post-traumatico la fisiologicità della sofferenza e dell’angoscia sono evidenti, però, cosa accade quando tale terremoto emotivo non viene sostenuto adeguatamente? Quali conseguenze possono subentrare?
Le conseguenze posso essere tante ma mi soffermo solo su una di esse che è strettamente riconducibile al disturbo descritto precedentemente, ovvero, l’Attacco di Panico.
Nella persona che soffre di attacchi di panico possiamo trovare l’esistenza di un trauma. Il trauma c’è, non è immediatamente riconoscibile, ma è lì, la persona lo sperimenta ogni qualvolta ha l’esperienza dell’attacco di panico. L’evento traumatico è rimasto sullo sfondo della vita della persona, nel mondo dell’indicibile, che, a sua insaputa, però, e in maniera improvvisa, attiva quelle paure e angosce arcaiche che tolgono il respiro e danno la percezione di una morte imminente.
“La persona che è assalita dagli attacchi di panico sento di colpo il senso dell’emergenza che avrebbe dovuto sentire nel momento del trauma. È proprio questa indicibilità dell’angoscia nell’insorgere dell’evento traumatico che lascia la persona che soffre di attacchi di panico indifesa davanti al senso di mancanza di controllo di ciò che le sta succedendo” (Francesetti, 2005).
La Psicoterapia come aiuta?
La psicoterapia consente di far sperimentare, alla persona che chiede aiuto, un nuovo senso di sicurezza attraverso l’esperienza del contatto con le sue fragilità perché sono proprie queste che danno una nuova spinta propulsiva alla vita. È sentendo le proprie insicurezze, le proprie fragilità che si dà la possibilità di fare esperienza delle proprie radici perché sono proprio queste che ci fanno sentire “ben piantati a terra”. E’ questa la sensazione che manca alle persone che soffrono dei disturbi descritti precedentemente, ed è solo attraverso la relazione terapeutica, nella stanza con il terapeuta, che l’indicibile trova spazio per diventare dicibile, e quando avviene ciò, diventa possibile trasformarlo come un pezzo di creta e fargli acquisire nuova forma e sostanza.
Dott. Irene Grado
Psicologa-Psicoterapeuta della Gestalt
Esperta in Psicodiagnosi Forense
Trainer di psicoprofilassi al parto: metodo Spagnuolo Lobb
Contatti: 338-9908067 e-mail: ire.gr@libero.it