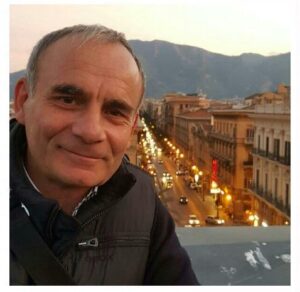di Beatrice Nencha

La notizia della condanna in appello di Piercamillo Davigo a un anno e tre mesi per rivelazione del segreto d’ufficio nella vicenda della famigerata Loggia Ungheria ha suscitato, come già in precedenza, una variegata scia di reazioni. Per la maggior parte di soddisfazione, mista a sottile ironia, per l’evidente contrappasso che ha colpito l’ex inflessibile magistrato del pool di Mani Pulite. Le cui infelici battute oggi si ritorcono come contro di lui, riaffiorando da un passato di cui – selettivamente – si ripesca solo ciò che fa comodo per screditarlo. Per tanti amici e colleghi di ventura, tentare uno straccio di difesa del loro collega un tempo stimato e preso a modello dovrà essere sembrata una battaglia persa: indifendibile a prescindere. Odiato dai media di opposizione, che giustamente non vedevano l’ora di azzannarlo, e fonte di imbarazzo per le testate che a lungo ne hanno avallato ogni aforisma, anche quelle più infelici (“Capitano i suicidi in carcere, peccato perché si perde una possibile fonte”, o il famigerato “non esistono innocenti, solo colpevoli non condannati”). Il problema non sono nemmeno le frasi in sé, quanto il fatto che non abbia mai sentito il dovere di ritrattarle o quanto meno di correggerle. E sono tanti gli episodi “illuminati”, anche quelli apparentemente insignificanti.
In aula a Brescia, Davigo racconta che prima di assumere la sua assistente di studio esterna, a cui ogni consigliere ha diritto e che lui prese solo per fare una cortesia ad Ardita, non esitò a sottoporla a un test di diritto amministrativo “per rendermi conto della sua preparazione”. Nonostante a raccomandarla fosse stata la sua segretaria storica, Marcella Contraffatto, presentandola come amica di famiglia e persona di massima fiducia, Questo è l’uomo. Ed è facile intuire perché, per la stragrande maggioranza delle persone, sia molto più facile solidarizzare con il ras delle nomine Luca Palamara, nonostante le sue gesta e le sue frasi, rivelate dalle chat, siano ben più imbarazzanti per il prestigio della categoria.
Piercavillo, detto anche “icona dell’inammissibilità”, è il soprannome che meglio riassume l’essenza di un uomo che ignora cosa sia l’empatia. E che oggi sconta il karma del furore giacobino con cui ha sempre giudicato ogni indagato e forgiato il suo personale concetto di giustizia. Esteso anche a quello di amicizia. Basti pensare a come si congeda dalla Contraffatto, una delle persone a lui più legate da una stima sincera: rimproverandola di essere stata troppo emotiva nei suoi confronti nel momento del suo congedo forzato votato dal Csm, “mentre lei doveva essere a servizio del Consiglio e doveva comportarsi come faceva con me”. Vai a spiegare a Davigo che si può piangere, e si può anche reagire scompostamente davanti a certe situazioni, perché i sentimenti sono legati alle persone e non alle targhe negli uffici.
Ma torniamo alla vicenda della presunta Loggia e degli interrogatori, non ufficiali, consegnati brevi manu a Davigo (“mortacci loro” sintetizzerà via sms proprio la sua assistente esterna, che evidentemente ce l’ha con chi ritiene abbia innescato tutta la vicenda, coinvolgendo il consigliere). E alla condanna confermata in Appello a un anno e tre mesi per aver creduto al contenuto dei verbali sottopostigli con urgenza da un altro magistrato, il sostituto Paolo Storari (giudicato col rito abbreviato e assolto, in primo grado e in appello, “perché il fatto non costituisce reato”), che denunciava la totale inerzia da parte dei suoi superiori della procura di Milano di fronte alle sconvolgenti rivelazioni.
Anche Storari è testardamente convinto della gravità e della fondatezza delle affermazioni dell’ex avvocato esterno dell’Eni Piero Amara, usate a suo dire solo a pezzi e bocconi dai suoi colleghi. Se paragoniamo le condanne ricevute, almeno inizialmente, proprio dal faccendiere siciliano, che certamente non ha dalla sua la scrinante dell’aver agito in buona fede – Amara lo dice apertamente che il suo unico interesse nei traffici che gestiva erano gli affari – la condanna di Davigo lascia perplessi per la sua durezza. Nella sua condotta, seppure maldestra, Davigo tenta di far conoscere il contenuto dei verbali ai suoi colleghi del Csm, che in tutti i modi tentano di respingerli come la peste, e cerca al contempo di tenerli segreti (con l’ingenuo metodo di seppellirli tra pile di scartoffie inutili “dove in genere nessuno guarda”, anziché nella cassaforte del suo ufficio, dove temeva potesse accedere qualcuno dei citati).
Soprattutto tenta di nascondere le carte al consigliere e suo collega di corrente Sebastiano Ardita, citato da Amara insieme ad altri 60 nomi di “adepti” della presunta loggia massonica, poi da lui stesso derubricata a “comitato di potere”, ovvero a lobby romanocentrica. Con l’unico risultato, prevedibilmente disastroso ottenuto da Davigo, di far esplodere l’intera indagine di Milano, su cui metterà una pietra tombale la Procura di Perugia, pur con vari distinguo e una formula ambigua. Ma grazie alla diffusione incontrollata degli interrogatori di Amara, la presunta loggia e i suoi presunti seguaci finiranno su tutte le prime pagine dei giornali. Con l’innesco immediato di svariate denunce, tra cui quella per calunnia e autocalunnia contro lo stesso Amara, con strascichi avvelenati in giro per le Procure d’Italia.
Una domanda fondamentale del processo è se Davigo fosse un soggetto titolato a ricevere atti privi di alcun riscontro di ufficialità e all’epoca coperti dal segreto d’ufficio da parte del collega Storari, che lui per primo rassicura. Sul punto, a Brescia ha deposto un ex consigliere del Csm, Giuseppe Marra, ascoltato il 23 febbraio 2023 come testimone assistito: “Il Csm riceve atti coperti da segreto d’ufficio sui magistrati, e anche le intercettazioni, e si attiva nelle sue diverse articolazioni. La comunicazione di atti secretati, atti di indagine, avviene quotidianamente al Csm ma la cosa anomala era la modalità di consegna di questi atti, che non erano arrivati al Comitato di presidenza per i canali formali. Davigo informa i vertici istituzionali al Csm ma nessuno gli fa domande sulla comunicazione formale. Il Consiglio di presidenza è l’unico organo competente ad aprire le pratiche ma la grande impasse, in tutta questa vicenda, è che all’epoca la procura di Milano non aveva mai fatto indagini”. Dunque, prosegue il magistrato, “dato che a Milano non era stato iscritto il procedimento sulla Loggia, non si poteva aprire una pratica da parte del Comitato di presidenza”.
Questa “impasse” è anche la metafora della pericolosità dell’ideale giustizialista che ispira Davigo, che pure è abituato a navigare tra i cavilli delle norme, ma non si accorge degli scogli all’orizzonte contro cui si andrà a sfracellare. Ma esiste la prova del dolo nella sua condotta? Semmai, ad ascoltare le udienze, appare il contrario: il suo è un eccesso di zelo che lo acceca completamente. E’ sempre Davigo a spiegarlo in aula a Brescia, davanti a una corte piuttosto diffidente nei suoi riguardi (sarà il karma), in un’altra dichiarazione spontanea del 13 ottobre 2022. Dove spiega le ragioni che lo portarono alla rottura definitiva, una volta lette le carte, col suo collega Ardita (a cui dovrà risarcire 20mila euro) e con altri protagonisti legati al Palamaragate: “Quando scoppia la crisi dell’Hotel Champagne Ardita cade in uno stato di prostrazione e mi dice almeno tre volte che vuole dimettersi dal Consiglio. Per quello che emergeva anche dalle intercettazioni, non c’era nulla contro di lui che potesse indurlo a questo e lui non sapeva darmi spiegazioni, però si chiude per 2-3 giorni nel suo ufficio con Lepre, che era uno dell’Hotel Champagne, quindi io mi inizio a preoccupare di tutte queste cose. Poi viene fuori che Ardita telefonava ad Amelio per parlare con Fava, che a sua volta andava nell’ufficio di Amelio per comunicare con Ardita.. Ma dopo che avevo saputo che questi si erano riuniti con un imputato della Procura di Roma per eleggere il nuovo procuratore capo di Roma, io non ho più dato la mano a nessuno di questi”.
Questo passaggio che descrive la forte preoccupazione di Ardita all’indomani della vicenda dell’hotel Champagne viene ricostruito, con più dettagli, anche in una memoria difensiva che l’ex sostituto procuratore di Roma Stefano Rocco Fava rilascia all’avvocato di Luca Palamara (entrambi a processo a Perugia, ndr).
Interessante è un altro passaggio delle dichiarazioni rese da Davigo a Brescia, che spiega le ragioni del suo comportamento nella gestione delle scottanti carte arrivate da Milano, alla luce della sua interpretazione dei verbali di Amara: “Quando ho saputo di Ungheria, è ovvio che ho reinterpretato una serie di accadimenti anche in questa luce. Quando leggo che uno dei soggetti più importanti è Cosimo Ferri mi ricordo che mentre ero alla Cassazione, Ferri mi telefonò per invitarmi a cena con la collega Tinell, membro laico del Csm in quota Pd. Quando arrivo a tavola trovo seduto anche Giancarlo Elia Valori (tra i soggetti citati da Amara, ndr), l’unico espulso dalla P2. Se avessi saputo della sua presenza, avrei declinato l’invito. Valori tira fuori una lettera, a firma di Francesco Saverio Borrelli che lo ringraziava per qualcosa, e lì ebbi la sensazione di essere oggetto di un tentativo di avvicinamento. Appena possibile me ne andai e da quel momento ho interrotto ogni rapporto con Ferri, perché non mi fai trovare un commensale di quel peso. Rievocando questo episodio, mi sono preoccupato ancora di più perché nei verbali di Amara, Elia Valori è indicato come capo di Ungheria in Sicilia e io potevo accertare che Ferri ed Elia Valori si conoscono dato che mi sono trovato con loro due a cena”. A furia di rompere i contatti con tutti, da ultimo quelli con Ardita a cui, come ricorderà la sua segretaria, “il consigliere ha sbattuto la porta in faccia”, Davigo è rimasto solo e, per giunta, l’unico senza toga. Solo con la sua velleità di “salvare” la categoria della magistratura dove, a quanto ci appare dall’esito di questa vicenda, vale il motto che ognuno faccia meglio a salvarsi da solo.