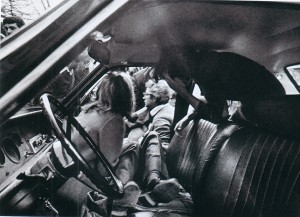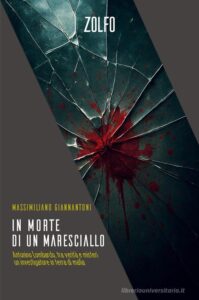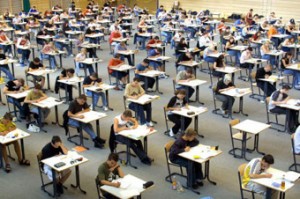Dopo trentuno votazioni in Parlamento è arrivata la nomina dei tre giudici della Corte Costituzionale, così da completare il plenum.
Dopo trentuno votazioni in Parlamento è arrivata la nomina dei tre giudici della Corte Costituzionale, così da completare il plenum.
Se un giudizio sintetico può essere espresso sulle qualità ei tre nuovi giudici, esso è certamente quello che, con il plenum non si è ristabilito quel prestigio di cui la Corte Costituzionale ha bisogno più di ogni altra Istituzione dello Stato.
Né c’era, francamente, da aspettarsi qualcosa di troppo diverso. Il grigiore, figlio legittimo della remissività e dell’arte di barcamenarsi che nel giro di non troppi anni ha distrutto la credibilità della scienza giuridica del nostro Paese, che aveva resistito anche alla non breve e serena notte del fascismo, non ha molto di più e di meglio da mettere in campo per dar nuovo lustro ad una Corte che pure, nei suoi primi anni di vita, ha raddrizzato molte storture create dall’inerzia (a dir poco) della classe politica di fronte all’eredità del fascismo ed ha goduto meritatamente di considerazione.
Ma a questa fondamentale ragione dell’inarrestabile (a quanto sembra) decadenza, si aggiungono altri motivi che in questa occasione si sono manifestati appieno, almeno agli occhi che non intendono rimanere saldamente e stoltamente chiusi.
Questa è stata un’elezione tipicamente “renziana”, espressione di una preoccupazione di occupare saldamente tutte le istituzioni che non si possono comodamente “rottamare”, con l’obiettivo di piegarne la natura, gli uomini che debbono esserne espressione, i metodi per reperirli e poterli nominare, alle esigenze contingenti e, soprattutto, a quella di non turbare il “gradimento” della gente e dare l’impressione di un “decisionismo” falso e, in sostanza, schiavo delle necessità della giornata e delle preoccupazioni delle percentuali di compiacimento del pubblico.
Mai un’elezione da parte del Parlamento era stata condotta, contrastata, condizionata da calcoli circa le previsioni di voto della Corte su questioni già ad esso devolute o, comunque, prossime ad essere oggetto di giudizio di costituzionalità. Basterebbe questo a definire l’elezione dei tre Areopagiti una catastrofe: per la Corte, per il Parlamento ed i rapporti tra i partiti e per tutta la Repubblica.
Ma c’è un aspetto più specifico e più facilmente rilevabile anche dai meno attenti osservatori della vita politica.
Si tratta dell’accordo tra Renzi (è inutile, oramai, parlare di P.D.) ed il Movimento “Cinque Stelle”.
Non sono tra quelli che, pur di fronte alle quotidiane esibizioni di idiozia politico-istituzionale dei Grillini, ritengono che sia un dovere di coscienza osservare la politica della loro emarginazione formale. Assai più mi preoccupa (l’ho scritto non appena hanno fatto irruzione in Parlamento) il tentativo di tagliar loro l’erba sotto i piedi cercando di batterli là dove sono imbattibili: nell’idiozia della retorica antipolitica.
Renzi è, in fondo, il prodotto di questa politica insulsa ed oltremodo pericolosa (come lo fu quella della D.C. di “assorbire” il Qualunquismo, che, però, riuscì, almeno formalmente, nell’intento).
Ma se Renzi ce lo troviamo sul groppone perché “ci salvava dalla barbarie dei Cinque Stelle”, il fatto che abbia cominciato ad intendersela con loro per “salvare le istituzioni”, potrà soddisfare chi era disposto a morire di fame perché “comunque” si ristabilisce il plenum della Corte, ma non può far aprire gli occhi e mettere in allarme chi abbia ancora un minimo di cervello in testa.
E, intanto, la modestia delle personalità scelte da qualche anno a questa parte dal Parlamento e dal Presidente, fa aumentare l’invadenza del Partito dei Magistrati, già rilevante, per altri motivi, nella Corte, dove una volta gli eletti dalla magistratura erano i giudici di meno elevata caratura e peso.
L’esclusione di Forza Italia dal giuoco “renziano” è qualcosa di più di un insuccesso tattico (se è stato tale).
Per battere l’ottusità dell’antipolitica e del “gradimento” di Leopoldino III non basta quel tanto di liberalismo che il partito di Berlusconi non è riuscito a scrollarsi del tutto di dosso.
Occorre un nuovo, aggressivo, pensante, liberalismo, capace di affrontare, magari, l’impopolarità, di rimanere fortemente e chiaramente all’opposizione del sistema, rinunziando all’etichetta di “moderatismo”, così sciocca e così cara al Cavaliere.
Un episodio, tutto sommato, almeno nella percezione della gente, marginale come quello di cui oggi ci occupiamo, ci ammonisce tutti: se vogliamo dirci ed essere uomini liberi, liberali (senza concessioni alla “damnatio memoriae” del meglio della nostra storia), se vogliamo che le libere istituzioni non si riducano ad un vergognoso inganno, dobbiamo non aver paura di essere, come siamo, minoranza oggi, per essere maggioranza vera domani. Mi costa moltissimo pensarlo e dirlo.
Il domani non mi appartiene. Ma ci sarà pure chi potrà viverlo e saprà meritarlo.
Mauro Mellini