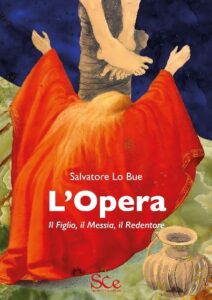Il 17 giugno 2013 è il ventiquattresimo anniversario della morte di mio padre. Ma è anche la data in cui OGGI.it pubblica, a firma di Edoardo Rosati, una notizia che mi riguarda (lo so, appare strano!, ma per me si tratta quantomeno di una sospetta coincidenza): il trapianto di testa presto si farà. Lo afferma con convinzione un neurochirurgo torinese di fama mondiale, il Professor Sergio Canavero, il quale, a fronte del numeroso materiale di natura scientifica che supporta le sue affermazioni, sembra non ottenere l’entusiasmo che si aspettava – anche perché, tra l’altro, è alla ricerca di 10 milioni di euro per continuare a finanziare la sua ricerca. difendendosi da tutte le critiche che nel frattempo gli sono arrivate. Intanto nel 2008 è stato capace di “spostare” con l’elettrostimolazione una ragazza da stato vegetativo permanente a stato minimamente conscio. Quisquilie, a confronto della notizia di oggi: il trapianto di testa è tecnicamente possibile e tra un paio d’anni addirittura realizzabile. Ingegneria cellulare, roba da sballo fantamedico, riconnessione del midollo spinale, in ipotermia profonda – cioè a circa 15 gradi, per salvaguardare le strutture cerebrali – la “possibilità di fondere i prolungamenti nervosi sfruttando delle sostanze in grado di ricostituirne l’integrità”. Il tutto inserito in un progetto denominato HEAVEN/GEMINI, Head Anastomosis Venture with Cord Fusion.
Il 17 giugno 2013 è il ventiquattresimo anniversario della morte di mio padre. Ma è anche la data in cui OGGI.it pubblica, a firma di Edoardo Rosati, una notizia che mi riguarda (lo so, appare strano!, ma per me si tratta quantomeno di una sospetta coincidenza): il trapianto di testa presto si farà. Lo afferma con convinzione un neurochirurgo torinese di fama mondiale, il Professor Sergio Canavero, il quale, a fronte del numeroso materiale di natura scientifica che supporta le sue affermazioni, sembra non ottenere l’entusiasmo che si aspettava – anche perché, tra l’altro, è alla ricerca di 10 milioni di euro per continuare a finanziare la sua ricerca. difendendosi da tutte le critiche che nel frattempo gli sono arrivate. Intanto nel 2008 è stato capace di “spostare” con l’elettrostimolazione una ragazza da stato vegetativo permanente a stato minimamente conscio. Quisquilie, a confronto della notizia di oggi: il trapianto di testa è tecnicamente possibile e tra un paio d’anni addirittura realizzabile. Ingegneria cellulare, roba da sballo fantamedico, riconnessione del midollo spinale, in ipotermia profonda – cioè a circa 15 gradi, per salvaguardare le strutture cerebrali – la “possibilità di fondere i prolungamenti nervosi sfruttando delle sostanze in grado di ricostituirne l’integrità”. Il tutto inserito in un progetto denominato HEAVEN/GEMINI, Head Anastomosis Venture with Cord Fusion.
Perché questa notizia mi riguarda? Che forse ho da trapiantarmi la testa perché la mia è un po’ troppo … fuori? Probabile. E la coincidenza? E mio padre? Ora mi spiego. La storia è semplice.
Nel 1978 mi sono iscritto in Medicina, Università di Pavia, tra le più rinomate. Ma il vero motivo per il quale mi ero iscritto a quella Università era ben altro.
Da dove venivo io, dire 1978 oppure 1956 era quasi la stessa cosa. A parte la tv, il frigorifero e la lavatrice solo da qualche anno erano entrate nelle case; un anno ben preciso, nella mia testa: 1972. Entro quell’anno, mi ricordo, i muli, gli asini, i cavalli e i carretti ancora in giro, diventarono “lape”, motozappe, leoncini (e persino qualche carrello dietro le fiat seicento, ottocentocinquanta e millecento) sempre con le sponde istoriate con le gesta di Orlando come nei carretti, e le carte napoletane, con l’asso di bastoni il più in mostra di tutti. Entro quell’anno le “pile” diventarono per la prima volta lavatrici e i “bummula” diventarono bottiglie d’acqua fresca nel frigorifero.
Da dove venivo io, l’alternativa per andar via senza soccombere era andare all’Università il più lontano possibile. Da Naro a Pavia 1600 chilometri di distanza impedivano alle nostalgie e alle manipolazioni affettive di agire.
Medicina, dunque. Subito le materie del primo anno: Istologia, Fisica, Chimica e Biologia; poi il secondo anno Anatomia e Biochimica. Il terzo anno Fisiologia e Microbiologia. Una serie di nozioni molto dense di natura scientifica, che entravano nel particolare, persino nel microscopico, oggettivando la materia ma lontanissimo dalle persone, a cui la mia formazione successiva mi avrebbe invece condotto.
La prima volta che entrai in contatto con la sofferenza da malattia, quella vera, non studiata al microscopio, ma vissuta sulla pelle giorno per giorno da persone che lottavano con tutte se stesse a favore della vita, è stato più o meno all’inizio del quarto anno, ma non perché previsto dalle programmazioni accademiche.
Tra le mie motivazioni interne (un modo come un altro per accogliere e forse giustificare in me le richieste implicite della mia famiglia, che comunque mi “spingevano” verso una carriera medica, soprattutto mio padre: ecco la coincidenza), la più suggestiva riguardava questo dilemma: se fosse stato più facile, almeno teoricamente, il trapianto del solo cervello o di tutta la testa, in toto, naturalmente con tutte le implicazioni etiche che una situazione del genere avrebbe potuto eventualmente generare. Sto dicendo la verità, e questo mi aveva spinto ad accettare di iscrivermi in Medicina con più entusiasmo, e comunque come una scelta all’apparenza indipendente dalle istanze familiari, che mi permise, del resto, di ottenere discreti risultati, per quanto mai degni della lode. Ma evidentemente, lo riconosco adesso, per mia pura negligenza e mancanza di applicazione e costanza, perché sul piano più squisitamente cognitivo ed emotivo, scoprii che ero molto considerato dai miei professori, e ne trovai la prima eclatante conferma proprio all’inizio del mio quarto anno, appena finito lo studio della fisiologia, ovvero del funzionamento normale del corpo umano, quando ancora non avevo neanche idea di cosa fosse una semplice infiammazione, figuriamoci tutta quella complessità di linguaggio e diagnosi e paroloni e meccanismi che nel loro insieme si chiamano PATOLOGIA.
Mi venne dunque in mente, anche se non avevo ancora nessuno strumento a disposizione che supportasse tale mia scelta, di recarmi al Policlinico San Matteo, rinomato allora per un sacco di cose, per le eccellenze in Ematologia, per esempio, nella Cardiochirurgia, nella Medicina dello Sport, nella Pediatria – ma soprattutto, per quanto mi riguardava, nella Neurochirurgia. Fu così che ne varcai l’ingresso del reparto. Figurarsi, una super specializzazione all’interno del dipartimento di chirurgia, io che non sapevo nemmeno distinguere in quel momento un mal di pancia da indigestione da un’altrettanto banalissima colica da gas. Cioè, volevo finalmente togliermi quel dubbio e capire che direzione dare ai miei studi universitari.
Mah. Forse ero incosciente, o forse ero veramente convinto, ed entrai senza nessuna soggezione di sorta, senza alcuna remora, sicuro dei miei fatti. Mi informai con la prima persona che indossava un camice, un’infermiera, mi ricordo, Sara: mi piacerebbe frequentare questo reparto, le dissi. Ma io, giuro, non avevo idea, se non molto vagamente, di cosa effettivamente si trattasse. Sei studente?, mi disse Sara. Certo, risposi. Ma non mi chiese altre informazioni, dando per scontato che io fossi laureando in cerca di una tesi se non addirittura laureato in cerca di specializzazione. Vieni, e mi portò in una sala con una decina di persone, anche loro in camice bianco. Si vedeva, comunque, che stavolta si trattava di medici, professori o assistenti di varie discipline: li sentivo parlare e ne comprendevo appena i ruoli e le mansioni: neurologia, elettroencefalografia, oncologia … oncologia?, mi chiedevo. Ma non è quella specialità che tratta dei tumori? Cosa c’entra qui? Davvero, me lo chiedevo con una ingenuità che tuttora mi fa sorridere di tenerezza verso me stesso. Sara mi disse che quello era il luogo e soprattutto il momento migliore per ottenere tutte le informazioni di cui avrei avuto bisogno. Ripeto, Sara mi introdusse perché dava per scontate le mie intenzioni, sicuro: in cerca di una tesi e quindi di una eventuale, conseguente specializzazione. E se ne andò, lasciandomi lì, in piedi. La maggior parte degli altri seduti o appoggiati ai tavoli che descrivevano il perimetro della stanza. E subito il più anziano di loro si rivolse a me: chi sei? Mi guardava con curiosità, mi ricordo, boh, probabilmente perché ero magrissimo, credo, ma anche perché avevo in testa il mio abituale cespuglio di capelli ricci che tra i miei amici e colleghi di Università mi avevano reso degno di una serie di nomignoli molto efficaci, devo dire: avete in mente il Lucio Battisti prima maniera? O Jimi Hendrix? Preciso, anzi di più: fungo atomico rendeva molto l’idea, ma anche Totigno, che mescolava intrigantemente il mio nome abituale, Totò (diminutivo di Salvatore) con quello di Toquigno, il famoso chitarrista brasiliano amico e collaboratore, tra gli altri, di Vinicious De Moraes – anche perché allora suonavo anch’io la chitarra (anche oggi a dire il vero). Insomma, dovevo sembrare davvero strano agli occhi di quei grandi professori, abituati a un certo rigore nei comportamenti, a una certa discrezione anche nel vestirsi, nel taglio dei capelli, eccetera, tuttavia non avvertivo sinceramente nessun imbarazzo. Eppure il più anziano mi chiese: che anno sei? Quarto, risposi, giusto l’inizio. Questo suscitò l’attenzione più profonda nei miei confronti. Che cosa ci facevo lì?, i loro sguardi questo dicevano, un pivellino del quarto anno, e per giunta all’inizio? Ah, disse l’anziano. Un altro, più dinamico e giovane, mi chiese: e come mai sei qui? Guardi, glielo dico subito: voglio scoprire se sia più facile trapiantare il cervello da solo o tutta la testa con un bel taglio a livello del collo. Cervicale. Ci fu dapprima un momento di silenzio. Poi scoppiarono letteralmente a ridere, come se io avessi fatto la battuta più comica dell’anno, molto apprezzata, naturalmente. Ma ti rendi conto?, si dicevano. Risa e commenti non si erano ancora spenti, quando entrò un signore bassino, scuro, curato quanto basta per darsi comunque l’aria del trasandato, con il camice discinto, le mani in tasca dei pantaloni, gli occhiali che sembravano cadergli dal naso, qualche pelo di barba non tagliato correttamente. Al suo ingresso i più giovani si zittirono subito, il più anziano lo accolse con un sorrisetto che gli indicava me. Allora?, che c’è di così comico?, disse l’appena arrivato. È simpatico il ragazzo, qui – come hai detto che ti chiami?, disse il più anziano col solito sorrisetto. Salvatore, risposi. Ah, Salvatore: io sono Alberto Vukotich, e qui sono il capo ricercatore, mi occupo della parte medico-farmacologica dei tumori cerebrali che trattiamo, siamo collegati al BTSG, sai?, Brain Tumor Study Group, uno studio mondiale, tu invece?… Ma non voleva darsi arie da superiore, e nemmeno io avvertii il minimo sfottò, anzi: era quasi divertito anche lui e tutto sommato mi metteva a mio agio, ma … Tumori? Cerebrali? BTSG? … altro che super specializzazione! In effetti, intuii che probabilmente si trattava di cose ancor più raffinate, e io che non sapevo nemmeno la differenza, tanto per rimanere in tema, tra un edema e un ematoma (che ancora da studente in medicina chiamavo pestone!) … ma dato che ormai c’ero! … e dato che in fondo mi sentivo malgrado tutto ancora a mio agio … Be’, gli dissi, voglio scoprire se sia più facile trapiantare il cervello da solo o tutta la testa con un bel taglio a livello del collo.
Lui mi guardò strano, ma molto serio, mentre gli altri continuarono a sorridere. Nel frattempo arrivò un altro medico, alto, stavolta elegante, con il camice anche lui non abbottonato, ma sopra un bel vestito grigio, camicia bianca e cravatta celeste, dal nodo impeccabile. Curatissimo, anche lui si sedette sul bordo di un tavolo, il piede destro ben poggiato a terra, la gamba sinistra leggermente penzolante – io mi ricordo ero seduto molto più in basso, su una seggiola comunissima! Probabilmente appoggiarsi sul tavolo era privilegio di pochi – e tutti si zittirono. Mmmh, fece guardando me e il capo ricercatore. Dunque stavi dicendo?, mi disse. E io per l’ennesima volta a ripetere: voglio scoprire se sia più facile trapiantare il cervello da solo o tutta la testa con un bel taglio a livello del collo. Ah, disse. Rimase serio a guardarmi per un po’. Stavolta nessuno rise. Va bene, disse, da domani mattina cominci. Era il primario, anzi: il Direttore sia del reparto, sia del progetto BTSG, il professor Aurelio Barnaba. Nessuno fece una grinza. Anzi, finalmente mi guardarono interessati, per accogliermi: Salvatore? … Nocera, aggiunsi, Salvatore Nocera – Bond, James Bond!, pensai. Uguale. Il giorno dopo il mio nome era affisso nella bacheca all’ingresso del reparto, con in alto quello del professore, giù giù quello di tutti gli altri addetti con la loro mansione, per finire con gli studenti interni: penultimo uno specializzando, ultimo io.
(Ora però mi viene un dubbio: non è che lo specializzando fosse proprio Sergio Canavero? – Io credo proprio di no, ma …?)