 La giustizia in Italia è una macchina lenta e farraginosa, è una vecchia signora stanca che vende i suoi servigi ad un prezzo discretamente elevato. I tribunali italiani hanno un numero di giudici assolutamente insufficiente a smaltire il carico del contezioso e pertanto un processo civile dura almeno tre anni, la prescrizione dei reati penali è all’ordine del giorno, il diritto è tutto tranne che certo. A ciò si aggiunga che il nostro parco legislatore negli ultimi anni per sopperire alla carenza di organico ha creato un sistema di precariato della giustizia, assumendo avvocati come giudici onorari, vice procuratori ordinari, giudici di pace con contratti quinquennali a tempo determinato ed ha aumentato i costi della giustizia: un cittadino Italiano, infatti, la giustizia la paga due volte: sia tramite le tasse, sia quando adisce le vie legali come contributo unificato. Questo è il catastrofico quadro della giustizia in Italia. Per reagire a tale stato di cose, circa due anni fa, è stato introdotto un sistema a costo zero per lo Stato cioè la mediazione obbligatoria ma tale sistema, per svista o per interesse, è stato costruito non in maniera da agevolare lo snellimento dei processi e di creare nuove figure professionali ma per avvantaggiare imprenditori privati lanciatisi in maniera speculativa nel business degli organismi di mediazione. Ovviamente ciò ha suscitato l’avversione degli ordini forensi i quali festeggiano la recente pronuncia della Consulta che ha bocciato l’istituto. Ad opinione della scrivente, tuttavia, festeggiano una vittoria pirrica, poichè festeggiano il ritorno di un immutato catastrofico quadro della giustizia senza porsi il problema di cercare sistemi alternativi per risolvere il problema. La mediazione potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento quale “palliativo” all’assunzione dei circa mille giudici di cui ha bisogno il Paese e per l’assunzione dei quali non ci sono soldi ma necessità di alcuni correttivi che potrebbero essere: il mediatore dovrebbe essere un dottore in legge abilitato da apposito esame presso corti d’appello e passibile di radiazione dall’albo in caso di ripetuta iniquità manifesta nei verbali; il mediatore dovrebbe essere un giudice di pace adibito alla mediazione cioè un tecnico abilitato all’esercizio della funzione che scelto dalle parti svolge con dignità il proprio servizio (e non un precario della giustizia con contratto quinquennale);i mediatori dovrebbero essere pagati “ a partita iva” ma esentasse, destinando a loro il 90% dell’obolo versato per ottenere la mediazione (e solo il 10% all’organismo di mediazione); solo l’attore dovrebbe essere onerato delle spese di mediazione, non dovendo sopportare altri costi in caso di impugnazione del verbale di mediazione davanti al giudice di primo grado (se impugnasse il convenuto invece pagherebbe il contributo unificato). Se si apportassero queste semplici modifiche non avremmo forse ottenuto: Il controllo della qualità della giustizia da parte dello stato, la creazione di nuove figure professionali , lo snellimento dei processi, l’abbassamento dei costi della giustizia da parte dello Stato e dei cittadini?
La giustizia in Italia è una macchina lenta e farraginosa, è una vecchia signora stanca che vende i suoi servigi ad un prezzo discretamente elevato. I tribunali italiani hanno un numero di giudici assolutamente insufficiente a smaltire il carico del contezioso e pertanto un processo civile dura almeno tre anni, la prescrizione dei reati penali è all’ordine del giorno, il diritto è tutto tranne che certo. A ciò si aggiunga che il nostro parco legislatore negli ultimi anni per sopperire alla carenza di organico ha creato un sistema di precariato della giustizia, assumendo avvocati come giudici onorari, vice procuratori ordinari, giudici di pace con contratti quinquennali a tempo determinato ed ha aumentato i costi della giustizia: un cittadino Italiano, infatti, la giustizia la paga due volte: sia tramite le tasse, sia quando adisce le vie legali come contributo unificato. Questo è il catastrofico quadro della giustizia in Italia. Per reagire a tale stato di cose, circa due anni fa, è stato introdotto un sistema a costo zero per lo Stato cioè la mediazione obbligatoria ma tale sistema, per svista o per interesse, è stato costruito non in maniera da agevolare lo snellimento dei processi e di creare nuove figure professionali ma per avvantaggiare imprenditori privati lanciatisi in maniera speculativa nel business degli organismi di mediazione. Ovviamente ciò ha suscitato l’avversione degli ordini forensi i quali festeggiano la recente pronuncia della Consulta che ha bocciato l’istituto. Ad opinione della scrivente, tuttavia, festeggiano una vittoria pirrica, poichè festeggiano il ritorno di un immutato catastrofico quadro della giustizia senza porsi il problema di cercare sistemi alternativi per risolvere il problema. La mediazione potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento quale “palliativo” all’assunzione dei circa mille giudici di cui ha bisogno il Paese e per l’assunzione dei quali non ci sono soldi ma necessità di alcuni correttivi che potrebbero essere: il mediatore dovrebbe essere un dottore in legge abilitato da apposito esame presso corti d’appello e passibile di radiazione dall’albo in caso di ripetuta iniquità manifesta nei verbali; il mediatore dovrebbe essere un giudice di pace adibito alla mediazione cioè un tecnico abilitato all’esercizio della funzione che scelto dalle parti svolge con dignità il proprio servizio (e non un precario della giustizia con contratto quinquennale);i mediatori dovrebbero essere pagati “ a partita iva” ma esentasse, destinando a loro il 90% dell’obolo versato per ottenere la mediazione (e solo il 10% all’organismo di mediazione); solo l’attore dovrebbe essere onerato delle spese di mediazione, non dovendo sopportare altri costi in caso di impugnazione del verbale di mediazione davanti al giudice di primo grado (se impugnasse il convenuto invece pagherebbe il contributo unificato). Se si apportassero queste semplici modifiche non avremmo forse ottenuto: Il controllo della qualità della giustizia da parte dello stato, la creazione di nuove figure professionali , lo snellimento dei processi, l’abbassamento dei costi della giustizia da parte dello Stato e dei cittadini?
N.B in merito al concorso in magistratura, si evidenzia che le sarebbe più coerente, come prova d’esame, la simulazione della scrittura di una sentenza cioè la risoluzione di un caso pratico. Si potrebbe sottoporre all’attenzione del candidato un caso pratico da risolvere e vagliare come un candidato agirebbe, come argomenterebbe una sentenza. Ciò in quanto la mera preparazione è elemento essenziale ma non sufficiente a dar garanzia di diventare un buon magistrato. Si potrebbe ancora settorializzare la carriera del magistrato prevedendo concorsi “per materia” (giudice penale, giudice civile, giudice del lavoro , giudice minorile ecc..) e focalizzando la preparazione del giudice sulla disciplina di cui si occuperà, prevedendo tre prove incentrate su tre aspetti differenti della materia (penale, civile, comunitario). Ancora, per smaltire ulteriormente il contenzioso civile, sarebbe d’uopo devolvere ad enti quali l’Autorità indipendente preposta alla tutela del consumatore (antitrust) e l’ente nazionale aviazione civile (enac), l’intero settore del contezioso inerente la violazione di regolamenti comunitari. Tali enti, ad oggi, nei casi di pratiche commerciali scorrette o di violazione di regolamenti comunitari, sanzionano le società, nulla però potendo disporre sul ristoro economico in capo al consumatore. Il consumatore è quindi tenuto ad adire le vie legali per avere un ristoro economico del danno subito. Ciò comporta che lo Stato sostiene i costi per mantenere suddette autorità che però rimangono lontane e svincolate dai destinatari delle loro azioni di tutela e che i cittadini debbano pagare per adire le vie legali con aggravio di spese a loro carico ed ingolfando i tribunali. Non sarebbe più razionale e più economico consentire all’enac ed all’antitrust l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei diritti del passeggero e del consumatore, senza dover adire un tribunale civile?!?.
L’abbinamento di un numero ad un elaborato nei concorsi pubblici è sicuramente il modo più semplice per truccare un concorso pubblico. Tale sistema infatti cerca di garantire l’anonimato del concorrente e come è notorio dove non c’è trasparenza c’è un’alta possibilità di imbroglio. Consegnare un elaborato non identificato mediante numero di serie in una busta sulla quale viene apposto un codice da modo : a) di cambiare l’elaborato all’interno della busta o b) di staccare un numero di codice da una busta ad un’altra, facendo si che un elaborato valido risulti prodotto da tizio piuttosto che da caio.
Il punto è che in un concorso Pubblico, svolto da una pubblica amministrazione che si basa sui principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che valore può avere la tutela dell’anonimato? Nel senso non sarebbe più facile mettere il proprio nome sul questionario e fare anche, come garanzia che non verrà sostituito il compito, una foto all’elaborato comprensiva del nome dell’autore, poi si procederà alla correzione che nei test avviene mediante lettore a fibra ottica, quindi senza alcuna valutazione di merito, ed in ultimo pubblicare una graduatoria con nome e punteggio ottenuto. Che bene stiamo proteggendo utilizzando l’illogico sistema dell’abbinamento? Ad opinione della scrivente, sociologicamente, stiamo proteggendo il senso di vergogna tipico della nostra società. Abbiamo infatti costruito una società della vergogna, a scuola si insegna solo a vincere ad ogni costo senza far capire il senso della sconfitta. Meglio faremmo invece ad insegnare il senso della sconfitta che altro non è se non uno stimolo a fare meglio per raggiungere il livello di preparazione già ottenuto da altri. Giuridicamente è un abominio: ogni atto o fatto ha sempre un autore o un responsabile; mantenere l’anonimato in un concorso pubblico che si caratterizzi per l’oggettività della prova sostenuta e la trasparenza degli atti non può che essere definito un abominio.
Si potrebbe porre qualche problema nelle prove concorsuali che richiedano una valutazione discrezionale sull’elaborato. Ma anche in quel caso la scrivente ha una posizione fortemente critica sull’effettivo perseguimento dell’obiettivo anonimato. Forse potremmo cercare di utilizzare prove selettive che diano poco spazio alla discrezionalità del commissario, impostando tutte le prove scritte mediante quiz nominali e con correzione mediante lettore ottico affiancate da una eventuale seconda fase orale tenuta in pubblica udienza.
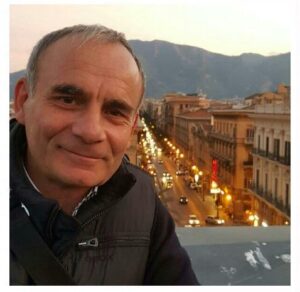

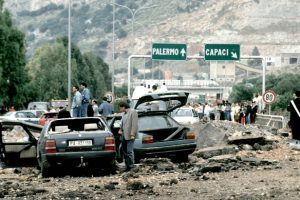


Gentile Roberta,
ho letto con interesse il tuo articolo, ed è doveroso rispondere, al solo scopo di informare il lettore che leggendo il tuo articolo potrebbe avere una visione distorta dell’argomento trattato.
Tutti i sistemi giudiziari Europei si avvalgono di giudici non togati e in alcuni di essi come il Regno Unito i giudici non togati sono un numero considerevole.
Il problema della Giustizia Italia non risiede nel numero dei Magistrati, i quali hanno un alto tasso di produttività e sono in numero adeguato se ci paragoniamo con gli altri stati europei. L’anomalia del nostro Paese è l’eccessivo ricorso alle aule di Tribunale, come segnalato di recente dal consiglio d’Europa. I rimedi sono principalmente il potenziamento nell’utilizzo di giudici non togati e il ricorso a metodi alternativi cosi detti ADR nello specifico mediazione ed arbitrato. Per quanto riguarda la mediazione, il 19 ottobre u.s. la sig.ra Arlene McCarthy relatrice della Direttiva sulla Mediazione ha elogiato il modello di mediazione italiano, auspicando che sia preso ad esempio per il resto d’Europa. http://www.inmediar.it/inmediar/index.jsp?idz=43&id=1732
Circa le tue critiche nei confronti degli organismi di mediazione che fanno affari con la mediazione, ti posso assicurare che l’affare in questo momento lo ha fatto il cittadino italiano, in quanto sono state stimate entrate nelle casse dello Stato per diversi milioni di euro, senza contare la creazione di almeno 2000 posti di lavoro in quanto il Ministero della Giustizia ha obbligato gli organismi ad assumere almeno 2 impiegati per la gestione della segretaria. Relativamente all’albo dei mediatori e la loro competenza giuridica, ti invito a leggere la normativa europea e a fare un paragone con altri sistemi in particolare quello statunitense che è uno dei più avanzati.
Da quanto leggo penso tu sia una giovane in cerca di un lavoro stabile e ben remunerato aspettativa legittima e condivisibile, ma i conti sulla mediazione non tornano. Se si dovesse destinare il 90% dei compensi di mediazione al mediatore e solo il 10% all’organismo, sarebbe necessario che il mediatore sostenesse i costi di gestione dell’organismo che attualmente vengono coperti a malapena. Lascio a te ogni ulteriore riflessione sull’istituto e per il futuro consiglio maggiore obiettività. Grazie per l’attenzione
Salve, come avrà capito la mia posizione è favorevole…credo nel sistema di giustizia privata. ma frequento il tribunale e gli ordini non tollerano gli organismi privati perchè lo vedono un mercato tutelato a vantaggio di pochi e senza regole sugli standard qualitativi. vogliamo fare 20 e 80 o 70 e 30 …mi sta bene …ma 50 e 50 è troppo…consideri che l’organismo guadagna sul numeo di mediazioni e sulle spese di avvio pratica (diverse dal contributo versato)…è un sistema moderato il mio , per accordare un pò tutti e risolvere le criticità evidenziate dagli ordini forensi. Cordialmente R.Z:P.s…sono giovane e cerco un modo per garantire più lavoro possibile a più gente possibile e con salari nei limiti del decoro.
Gentile Roberta,
nel suo articolo ho colto la sua predisposizione per l’istituto della mediazione,
ma si evidenziano comunque dei preconcetti che scaturiscono da una scarsa conoscenza del mondo ADR.
Circa i compensi ai mediatori, prima di scrivere quanto riferitole nei corridoi dei Tribunali, da buona giornalista dovrebbe approfondire la sua conoscenza sul tema.
S’informi meglio, ascolti anche le altre campane e non solo persone che vedono gli organismi come un affare.
Si rechi presso un organismo privato e veda quanto è difficile mandare avanti una struttura con i 48,40 delle spese d’avvio.
Attualmente la retribuzione di un mediatore alle prime armi è del 30%, salvo che si faccia carico dei costi di gestione.
La saluto e la ringrazio per la risposta
🙂 opinioni differenti…io non sono una giornalista….e converrà con me che rendendo obbligatoria la mediazione e prevedendo un numero di circa 10 mediazioni al giorno sono già 480 euro per l’organismo nette….in un mese sono circa 10/12 mila euro….e sto volando basso e senza aggiungere la quota da contributo di mediazione…..mi sembra che la mia proposta non sia cosi irrazionale, oltre ad essere un modo per “salvare” l’istituto. Cordiamente