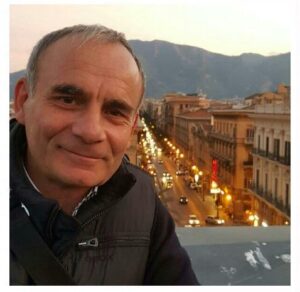L’argomento di cui intendiamo parlare questa settimana è la tutela del consumatore.
E’ certamente un argomento vasto che non potrà essere discusso in un solo articolo ma che richiede più articoli.
L’obiettivo sarà quello di consentire ai lettori di conoscere quali strumenti il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione per tutelare i propri diritti di consumatori, come potrà contestare un difetto di una merce acquistata, entro quali tempi e con quali possibilità di successo.
Il nuovo Codice del Consumo è stato posto in essere con il decreto legislativo 206/2005 che rappresenta l’esercizio della delega conferita al Governo con la legge 229/2003.
Tale codice si inserisce in una fase di incisiva ridefinizione delle politiche comunitarie in materia di diritti dei consumatori.
Il nostro codice del Consumo ha operato un allargamento del concetto di consumatore rispetto alla definizione data dalla direttiva europea, infatti per l’art. 3 lett. a) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta mentre l’art. 5 intende il consumatore anche come colui, persona fisica, al quale sono dirette le informazioni commerciali.
Questa anticipazione delle tutele ad una fase precedente dell’acquisto del bene o del servizio è la naturale conseguenza, da un lato, del riconoscimento del diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità tra i diritti dei consumatori, contenuto all’art 2, comma 2, lett c) del codice, e dall’altro, della scelta degli estensori delle norme in commento di riorganizzare le disposizioni a tutela dei consumatori con riferimento all’intero processo di consumo, attribuendo un particolare rilievo all’informazione, per consentire al consumatore di operare scelte consapevoli. Considerare consumatori anche i destinatari delle informazioni commerciali vuol dire anticipare le tutele e rendere evidente che il consumatore può essere parte di rapporti tanto contrattuali quanto extra contrattuali e precontrattuali.
La nozione di consumatore contenuta nel codice è una definizione negativa, neutra poiché prescinde dal tipo di contratto o di attività coinvolta dall’atto di consumo ma anche una definizione vaga, non essendo idonea ad identificare una precisa categoria di soggetti dal momento che la qualità di consumatore è temporanea, provvisoria, reversibile, legata al concreto atto di consumo posto in essere.
Il consumatore è per definizione una persona fisica e quindi la sua disciplina è inapplicabile non solo alle società ma anche agli enti collettivi, quali associazioni, comitati, fondazioni, cooperative anche se la loro attività si caratterizza per la mancanza di un fine di lucro.
Tale principio è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia che nel 2001 ha confermato una posizione intransigente sostenendo che la nozione si riferisce solo alle persone fisiche e poi anche la Corte Costituzionale che con la sentenza del 22 novembre 2002 n. 469 ha ribadito l’esclusione di soggetti, quali artigiani, professionisti e piccoli imprenditori, che proprio per l’attività abitualmente svolta hanno sufficienti cognizioni per negoziare su un piano di parità, tale per cui l’assimilarsi ai consumatori contrasterebbe con lo spirito della direttiva e la normativa comunitaria.
Ma entriamo a trattare dell’argomento della tutela del consumatore innanzi ad un prodotto difettoso.
Prima di tutto va detto che il codice definisce prodotto ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, compresa l’elettricità.
La tutela si estende quindi oltre ai beni mobili definiti dall’art. 812 c.c., alle cose mobili che risultano incorporate in cose immobili, intese come prodotti utilizzati per realizzare cose mobili, come il cemento, i prefabbricati incorporati nell’edificio finale, o quali componenti aggiunti ad un immobile quale l’ascensore, l’allarme.
Dalle definizione di prodotto sono escluse principalmente tre tipi di beni; gli immobili nel loro complesso, le opere dell’ingegno immateriali e i servizi.
Ai sensi dell’art. 117 del codice un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze.
La difettosità si valuta sulla base del livello di sicurezza che esso esprime non come valore in termini assoluti bensì in termini di ragionevolezza in base ad una valutazione oggettiva del consumatore medio.
La valutazione del livello di sicurezza che ci si può attendere da un prodotto deve tener conto del modo in cui esso è stato messo in circolazione, l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e il tempo in cui lo stesso è stato messo in circolazione.
Pertanto, il produttore è tenuto ad evitare che il proprio prodotto sia affetto da difetti di progettazione, di fabbricazione, di carenza di informazioni e difetti da osservazione del prodotto che ricorrono quando il difetto compare dopo l’immissione in commercio dello stesso, magari anche a seguito di un progresso scientifico o tecnologico avvenuto dopo l’immissione del prodotto in commercio.
Gli artt. 114 – 127 trattano della responsabilità del produttore che è una partizione nell’ambito della responsabilità civile riguardante specificatamente l’attività della produzione di prodotti e il regime di responsabilità da applicare, allorché il prodotto sia difettoso ed arrechi danni a chi lo consuma o a terzi.
La direttiva comunitaria 85/374/CEE stabilisce che il produttore è responsabile per il danno determinato da un difetto del prodotto ma il danneggiato ha l’onere di provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno mentre spetta al produttore l’onere di dimostrare i fatti che possano escludere la responsabilità secondo quanto stabilito dall’art. 118.
La legge stabilisce che in capo al produttore vi è l’obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e se non vuole incorrere in responsabilità deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall’uso anormale del prodotto poiché la carenza di istruzioni per l’uso costituisce una ipotesi di mancato rispetto delle regole sulla sicurezza del prodotto.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità oggettiva del produttore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.
Questo termine triennale che è più breve del termine ordinario previsto dall’art. 2947, comma 1 c.c., comporta che solo nel caso in cui il danneggiato faccia valere i danni subiti entro il termine potrà avvalersi del regime di responsabilità oggettiva del produttore altrimenti, nel caso in cui l’azione sarà fatta valere dopo i tre anni ma entro il termine di cui all’art. 2947 comma 1 c.c., il danneggiato dovrà anche dimostrare la colpa del produttore.
In nessun caso comunque il produttore è tenuto a rispondere dei danni causati da un difetto del suo prodotto, allorché siano trascorsi dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto.
Nel prossimo articolo ci occuperemo del diritto di recesso da acquisti in locali commerciali o fuori da essi e nelle vendite a distanza esaminandone gli aspetti tecnici, la forma e il termine di decadenza.
Cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello
aielloavvgiuseppe@libero.it
cell. 3389622713